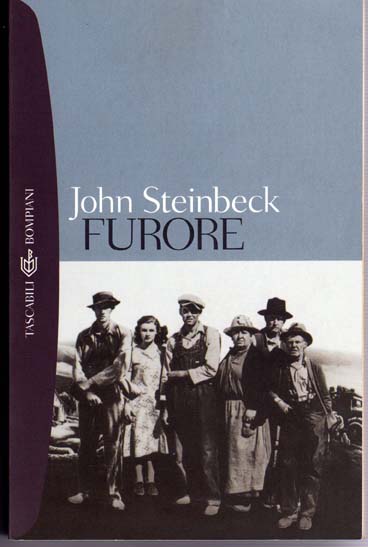|
| Cat in the Grass by *sesfitts |
Una grossa goccia di caffè cadde sulla prima pagina, diluendo la faccia di un primo ministro. La grassa M del titolo di testa sbiadì e si contorse come un lombrico, colando lieve ai lati. Mi affrettai a togliere la tazzina dal giornale, confinandola nell’angolo più lontano del tavolo. Asciugai la chiazza, ma non ci fu verso. Il primo ministro era e restava leggermente beige. Pregai che non lo venisse a sapere.
Ogni mattina facevo colazione in un piccolo bar di Piazza Tre Venti, cornetto e caffè o cornetto e cappuccino. La proprietaria non era una bellezza, ma ci sapeva fare col gomito, quando lucidava di forza il bancone. Mi divertivo ad osservarle i seni costretti dentro la camicetta bianca.
Compravo un paio di quotidiani nell’edicola a cento metri da casa e una copia del giornale locale, per tenermi aggiornato. Li sfogliavo distratto piluccando un croissant o leggevo qualche paragrafo tra un sorso e l’altro di caffè. I quotidiani non mi interessavano, ma leggerli bisognava leggerli, almeno per sapere di cosa parlare durante il giorno. La gazzetta locale, invece, era tutto colore, dall’articolo sugli allevatori di conigli a quello sulla raccolta differenziata.
La proprietaria venne a portar via la tazzina e, guardandomi coi suoi occhi di gatta, chiese implorante:
« Ti porto altro? »
« No, no grazie » sorrisi di rimando.
Non mi piaceva, ma volevo tenermi aperto uno spiraglio, nel caso un giorno avessi avuto bisogno di contatto umano.
Spolverai dalla tovaglia le briciole di cornetto, piccoli ritagli di pasta sfoglia e un puntino di crema, poi aprii il giornale locale e ne distesi pian piano le pagine. Ogni momento andava gustato fino in fondo. Il cinema aveva aumentato di un euro il costo del biglietto. La moglie del sindaco era stata vista a spasso con un altro. Una signora si lagnava della fossa settica intasata. A marzo uno scrittore dava una conferenza. Andavo fuori di testa per la sezione degli annunci. Cercasi badante automunita. Cedesi attività commerciale ben avviata in Via Bramante. Laureanda in Lingue e Lettere Straniere offre ripetizioni di tedesco a prezzi modici. Regalasi cuccioli di pastore tedesco. Vendesi autoradio con ingresso mp3 quasi nuova. Una volta avevo composto il numero scritto in grassetto per il solo gusto di sentire quanto volevano per un’aquila reale impagliata.
C’erano anche riquadri pubblicitari, sgraziati box celesti o gialli in cui campeggiavano lettere minute. Pizzeria Da Massimo. Vanni Autobus a Nolo. Il Serraglio Verde, lo spaccio per mangimi in cui lavoravo. Le loro grafie contorte o avvitate come pampini mi erano ormai familiari: era raro che un nuovo spazio pubblicitario si andasse ad aggiungere a quelli degli storici commercianti locali. Ma quel giorno una piccola nuvola violetta in alto a destra di pagina 6 attirò la mia attenzione. Ero sicuro, totalmente sicuro che quella fosse la sua prima comparsa. Come ero sicuro di essere il primo, forse il primo in tutta la città, in tutta la provincia, ad averla notata. Agenzia Persefone, Agenzia Persefone, pensate! Che delicata sfumatura e che promessa di sicuro successo commerciale.
Avevo bisogno di un’Agenzia Persefone? Cosa poteva offrirmi la loro nuvola paffuta? Lessi la dicitura sotto il nome, scritto a caratteri cubitali. “Tutto il conforto che avete sempre desiderato nei vostri momenti difficili. Assistenza terapeutica e sostegno psicologico sempre a portata di cornetta. Chiamateci e fissate un incontro con i nostri operatori: saremo ben lieti di porgervi orecchio”. Seguiva un numero verde.
Doveva essere una di quelle discrete, moderne macchine succhia-soldi. Si cominciava con un piccolo amuleto, poi un mucchietto di sale, qualche mazzetta dentro una busta da lettere, una pacca sulle spalle. Mi chiedevo perché il Comune autorizzasse simili scempiaggini. Di lì a un mese ci saremmo trovati sul collo tutta la troupe di Striscia la Notizia, ne ero certo.
Richiusi il giornale e lo arrotolai insieme cogli altri, cacciandoli sotto al braccio, poi mi avvicinai alla cassa stringendo tra le dita una banconota da cinque euro. La proprietaria mi fece scivolare nel palmo un paio di monete di resto.
Quando non pioveva raggiungevo a piedi l’ufficio e difatti quella mattina non pioveva. Via Bramante era deserta, salvo pochi passanti. Una signora coi capelli raccolti aveva portato fuori il cane. Un ragazzo sui sedici avviava il motorino. Qualcuno faceva uscire da un garage una Panda celeste. L’orologio segnava le otto e mezza: l’assenza dei miei sonnacchiosi compaesani era giustificabile. Difficile da giustificare era invece il mio datore di lavoro. Non capivo perché si dovesse aprire così presto, visto che non c’era un cliente prima delle dieci.
La serranda del Serraglio era già sollevata. Un operaio stava scaricando da un furgoncino bianco dei sacchi di becchime per polli. Il proprietario sovrintendeva allo smistamento nei vari reparti del locale.
« Attento, se mi butti giù quei vasi li paghi, eh! » ringhiava, senza muovere un passo « Dì là, di là, quello è dei conigli! Ma non avevo ordinato questa qualità, che roba sarebbe, con cosa la fanno? Non vogliamo grane, noi! »
Il proprietario era grosso, scorbutico, una palla al piede. Per fortuna io lavoravo in ufficio, un piano sopra il negozio: rispondevo al telefono, mi occupavo degli ordini, contrattavo sul prezzo. Non lo vedevo che all’entrata e all’uscita.
Lo salutai con un cenno, poi mi fiondai su per le scale, gettando appena un’occhiata al vasto intrico di scaffali e di sacchi, grosse teste di animale che gongolavano dagli incartamenti, una pila di voliere accatastate. Al secondo piano c’erano due uffici e un bagno. Un ufficio era il mio, l’altro di Greta, la contabile. Mi affacciai sulla porta per salutarla e la trovai dietro la scrivania, come di consueto, i grossi occhi nei grossi occhiali rotondi fissi sul monitor del pc. Alzò la testa, facendo ondeggiare la coda di cavallo, e disse:
« Buongiorno! »
« Problemi con gli ordini? » chiesi, indicando col dito un piano sotto.
« Al solito. S’è svegliato male » fece lei, rilassando le spalle.
I suoi occhi a palla non erano belli sul viso sottile, dal mento allungato, ma erano rassicuranti. Rassicurazione, ecco cosa si poteva sempre trovare in Greta.
La lasciai che si accaniva sulla tastiera con le unghie laccate di rosa e aprii la porta del mio ufficio. La stanza aveva il familiare odore di mangimi che filtrava dal piano di sotto. È difficile descrivere di che odori si tratti a chi non l’abbia mai avvertito di suo. È un odore di animali ma neanche poi tanto, l’odore dei campi concimati quando è piovuto, quel pizzicore alle narici. Penserete che, sentendolo tutti i giorni, uno dovrebbe esserci abituato, così abituato da non farci più caso. In realtà non è facile abituarsi a un odore, quando si vive in più odori allo stesso tempo. La mia cucina sapeva di cavolo, il bagno di dopobarba, il bar di caffè espresso, l’ufficio di mangimi. Nel passare dal tanfo di cavolo a quello di mangimi si coglie sempre la differenza e, nel breve lasso di tempo in cui l’avverti, rimpiangi sempre l’odore che c’era prima.
Il pianale della scrivania era disseminato di carte: carte appallottolate, pile di carta, un aeroplano di carta, una carta di caramella. Far pulizia non era propriamente il mio forte. Anche il cestino della carta straccia traboccava e dovetti esercitare una certa pressione per persuaderlo ad accettare nuovi occupanti. Quando lo schermo del pc risultò visibile al di sotto della montagna di spazzatura, giudicai che fosse il momento di sedermi.
Impiegai circa mezzora a riordinare le fatture che si erano accumulate tra lunedì e martedì. Badai che non me ne sfuggisse nessuna e le catalogai per entità dell’importo. Non mi piaceva che Greta pensasse che ero trascurato. Feci qualche telefonata: dovevo informarmi sul prezzo di una marca di lettiera profumata al limone e fissare una consegna per il giorno seguente.
Verso le dieci e dieci risposi a una chiamata del canile. Una donna dalla voce monotona ordinò venti sacchi di croccantini per cani da 3 euro e 99 l’uno, sette nuove ciotole di plastica blu, dieci ossi finti e dodici confezioni di crocchette per gatti. Trascrissi tutto su un post-it, poi chiesi:
« È sicura sulle crocchette per gatti? »
« Certo, sicura, dodici pacchi. »
« Ma davvero sicura? »
« C’è qualche problema? »
« No, no, nessun problema. La consegna è domani col resto. Ma mi chiedevo se... » prolungai volutamente la pausa, in modo da accrescere la sua curiosità. E difatti la signora non smentì la sua natura di Pandora.
« Che cosa? » domandò, un tono sopra il normale.
« Ho sentito storie sulle crocchette per gatti che la farebbero rabbrividire. »
« Oh bella, che storie? » adesso aveva una voce da sorcetto.
« Uno che le produce lo raccontava il mese scorso. Contengono degli additivi chimici che provocano assuefazione. Come una droga, capisce? »
« E poi? »
« Eh, poi i gatti non possono mangiare altro che quelle. Sono come in astinenza. »
«Oh, povere creature. Che si fa dunque? »
« Disdico l’ordine? »
La donna ci pensò su un secondo. La sentii respirare all’altro capo della cornetta.
« No, no » disse lentamente « Non saprei che altro dar loro da mangiare. »
A malincuore rinunciai a tracciare una riga sopra la dicitura “Croccantini Miau dodici pacchi”. Riepilogai il tutto, ringraziai e riagganciai. Mi sentivo pesante.
Greta sbirciò dalla soglia con un sorriso.
« Di nuovo la storia dei croccantini » mi canzonò.
Io le sorrisi in risposta, incerto. Nessuno voleva mai prendermi sul serio.
Quando rientrai a casa erano le cinque e trentacinque. Ryanair mi accolse con uno zampettare deciso sul pavimento bianco, i cuscinetti adiposi che attutivano il rumore. Mi si strusciò contro le gambe e prese a miagolare. Io appesi la giacca a un gancio, poi mi chinai per accarezzarlo tra le orecchie. Il pelo era ruvido: aveva bisogno di un bagno. Anch’io avevo bisogno di un bagno, decisi, avvertendo il discreto odore di cavolo della cucina.
In camera mi spogliai e gettai i pantaloni nella cesta della biancheria, che traboccava quanto quella della carta. Era ora di passare in lavanderia. Aprii la finestra per arieggiare la stanza, coperta e lenzuolo ancora abbracciati l’uno all’altra, spossati come dopo un lunghissimo amplesso. Ero disordinato, disordinato da morire.
Riempii la vasca fino a metà, saggiando la temperatura dell’acqua di tanto in tanto. Versai una generosa quantità di bagno schiuma e restai ad osservare le bolle che scoppiavano allegre. Ryanair allungò una zampetta per ghermirne una.
« Adesso fuori! » tuonai. Non so perché, ma spogliarmi davanti a lui mi imbarazzava.
Il gatto filò via a coda dritta.
Scavalcai la vasca con una gamba e mi accasciai contro lo smalto bianco, le mani che penzolavano fuori. Fissavo il tubo dello scaldabagno, facendo il punto della situazione. La fornitura per il canile. La lavanderia. Telefonare alla mamma. La cena. Doveva esserci del prosciutto avanzato. Forse era rancido. L’avrebbe mangiato Ryanair. Carciofi sott’olio? Decisamente no. Decisi che era meglio una spaghettata.
L’acqua mi puliva il corpo dagli odori. L’aiutai con la spugna e mi feci uno shampoo. Quando non rimasero più bolle e le mie gambe furono tutte visibili sotto la superficie crespa, mi alzai e mi avvolsi nell’accappatoio. Dopo sarebbe toccato a Ryanair.
Mi frizionai i capelli con l’asciugamano e uscii dal bagno, trascinando a penzoloni la cintura dell’accappatoio. Ryanair cercò di acchiapparla mentre strisciava sul pavimento. In frigo c’era effettivamente del prosciutto. Aprii l’involto e lo annusai: mandava ancora un buon odore. Lo tagliai a striscioline sottili e riempii la ciotola di Ryanair, che si mise a masticare con avidità. Quando ebbe finito, guardò in su attraverso gli occhi gialli e si leccò i baffi.
« Dopo la pasta » dissi.
Composi dal fisso il numero di mia madre. Stava facendo le tagliatelle per domenica.
« Il pranzo, te lo ricordi? » mi chiese in apprensione.
« Sì, certo » mentii convincente.
« Viene anche Raffa. »
« Anche i bambini? »
« Dove pensi che li lasci? »
« Certo. »
Mia sorella si trascinava sempre dietro un chiassoso stuolo di marmocchi, età imprecisata tra gli otto e i tre. Non che non mi piacessero, no, ma non ero abituato ad averli attorno. Il più piccolo mi si arrampicava sulle ginocchia e pretendeva di giocare a un gioco che non conoscevo, cavallino cavallino o qualcosa del genere. Era seccante fare brutte figure con un bambino.
La mamma mi chiese se mangiavo, come stava Greta, se sarebbe venuta, se il lavoro andava bene, e il gatto?
« Devo fargli il bagno. »
« Non si fa il bagno ai gatti! » protestò.
« Solo perché tu non glielo fai. »
La gente dalle mie parti era disgustosamente pragmatica.
Fu un sollievo quando potei lasciar cadere la cornetta e sprofondare nel divano, telecomando alla mano.
E fu in quel momento, mentre alla tv andava la striscia quotidiana del Grande Fratello e Ryanair premeva la testa contro le mie gambe nude e l’accappatoio mi si incollava freddo alle scapole, fu in quel momento che tutta la giornata mi cadde addosso, come faceva quasi sempre a quell’ora. Era uno strano precipitare su se stessa, un accartocciarsi del tempo, un contrarsi delle distanze. Spezzoni di ore mi ripassavano davanti agli occhi, insignificanti, neppure troppo umoristici. Potevo passare dall’uno all’altro proprio come cambiavo canale col telecomando, ma non cambiava la sostanza delle immagini, come il tg di Italia Uno non era migliore di Pinco Pallino al Grande Fratello. Le inquadrature erano piatte ed irritanti. La mia vita e la mia giornata non avevano un senso, ecco cosa dicevano i primi piani. Ieri era uguale a oggi che sarebbe stato uguale a domani. Tanto valeva spegnere la tv e spegnersi lì, in quel momento, sul divano, con l’accappatoio addosso e Ryanair che miagolava per le stanze vuote, cercando qualcuno che gli riempisse la ciotola.
Tutto il conforto che avete sempre desiderato nei vostri momenti difficili. Come aveva ragione quell’Agenzia Persefone. Certi momenti erano davvero difficili. Ma non perché succedeva qualcosa di brutto. La verità è che non succedeva niente.
Saremo ben lieti di porgervi orecchio. Davvero, volete davvero ascoltare la mia voce? Le vostre orecchie si staccherebbero per la noia, i vostri operatori si appisolerebbero sulla cornetta.
Ebbene, se siete così gentili e disponibili, tanto vale provare. Un numero verde non costa niente e Ryanair ha sempre fame.
Trascinai di una ventina di centimetri il tavolinetto del telefono, per averlo a portata di mano senza alzarmi dal divano. Ryanair mi fissò con aria sospettosa.
« Zitto » lo liquidai.
Composi il numero controllando dal giornale. Sbagliai a digitare e ricominciai da capo. Gli otto e i tre mi si confondevano negli occhi, completandosi o dimezzandosi a vicenda. Tu-tu-tu. Tre tu, poi lo scatto.
« Risponde l’Agenzia Persefone! »
Mi affrettai a riagganciare. Ryanair mi saltò in grembo e cominciò ad arrotare le unghie sull’accappatoio, come se volesse punirmi per quella stramberia. Gli accarezzai la testa e ricomposi diligente il numero.
« Risponde l’Agenzia Persefone. »
Meno squillante di prima, forse rattristata di aver perso un potenziale cliente.
« Buonasera » dissi, imbarazzato.
« Buonasera, in cosa possiamo esserle utili? »
Silenzio. In cosa potevano essermi utili? Pensavo che mi avrebbero chiesto di scegliere un piano tariffario. La voce era quieta, ma affabile: cercava di mettermi a mio agio. In cosa potevano essermi utili? Cosa facevano esattamente?
Ma sembrava che il mio silenzio fosse abbastanza esplicito per l’interlocutore.
« Ci ha già provato? »
Provato? Non sapevo.
« Sì » risposi, dandomi un tono deciso.
« Quante volte? »
« Una. »
« Come? »
Di nuovo silenzio.
« Non importa, non importa, non si preoccupi. Ora come sta? »
« Meglio. »
« È già qualcosa. Ha parenti, amici che possano aiutarla? »
« No, non vicino. »
« Ne ha parlato con altri? »
« No. »
« Non le fa bene. Dovrebbe parlarne con qualcuno. Scriva, almeno. »
« Ho un gatto. »
« Ne parli con lui. Verbalizzare fa sempre bene, anche se non c’è nessuno ad ascoltarci. »
La voce era tesa. Ho già detto che era una voce femminile? Non particolarmente acuta, non brillante come quella di Greta, della barista, della donna-canile, ma certo femminile, dal tono materno. Più materna della voce di mia madre.
« Ha pensato di riprovare? »
« Sì…no. »
Qual era la risposta corretta?
Ma la donna all’altro lato non sembrò preoccuparsene:
« La capisco, mi creda, la capisco. In entrambi i casi, sappia che può sempre contare su di noi. Deve imparare a fidarsi del suo prossimo, ad aprirsi al mondo, a costringerlo a piegarsi alle sue decisioni. Le sue decisioni sono importanti, capisce? Lei è importante. Le sue decisioni devono essere rispettate. »
Il tono era in qualche modo alterato, ora:
« E non creda a quello che le diranno. Il potere di decidere spetta soltanto a lei. Ma dev’essere una decisione consapevole, non la risposta a un impulso. E noi siamo qui per questo, per aiutarla ad attuare la sua decisione nel miglior modo possibile e guidarla attraverso questa fase delicata. »
« Certo » risposi stupidamente « E vi ringrazio. »
« È il nostro lavoro » si giustificò lei, vergognosa.
« Vuole che le fissi un appuntamento? » chiese.
« Sì. »
« Va bene domani? »
« Sì. »
« In che fascia oraria lo preferisce? L’agenda è sgombra. »
« Nella pausa pranzo, possibilmente. Tra l’una e le tre. »
« Le due va bene? »
« Perfetto. »
« Perfetto. Allora a domani, signor… »
Ryanair miagolò di rabbia. Lo stavo ignorando da troppi minuti. Strisciò deciso il muso contro il mio torace.
« Signor Ryan Air. »
« A domani, signor Air. E si ricordi, verbalizzi! »
Il tu-tu cadde sulla voce di mia madre. La cornetta mi sfuggì dalle mani e cadde sulla testa del gatto, che saltò giù dal divano.
« Dove vai? » dissi piano « Dobbiamo parlare. »
Per tutta risposta Ryanair alzò la coda e orinò contro il divano.
Di Chiara Pagliochini